
TITOLO LIBRO: Hunger Games – Ballata dell’usignolo e del serpente
AUTORE: Suzanne Collins
TRADUTTRICE: Simona Brogli
PROGETTO GRAFICO E COPERTINA: Elizabeth B. Parisi, Tim O’ Brien
GENERE: Narrativa
EDITORE: Mondadori
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2020
PAGINE: 478
CODICE ISBN: 978-88-04-72266-3
GIUDIZIO: ★★★★☆
«La gente gli avrebbe dato del tiranno, crudele e con il pugno di ferro. Ma almeno lui avrebbe garantito la sopravvivenza per il bene della specie, offrendo agli individui la possibilità di evolvere. In cos’altro poteva sperare l’umanità? In realtà, la nazione avrebbe dovuto ringraziarlo.»
A qualche anno di distanza dalla conclusione delle gesta di Katniss Everdeen e della rivoluzione dei distretti di Panem, Suzanne Collins si fa artefice di un ritorno trionfale nell’universo brutale e straniante di Hunger Games.
64 anni prima degli eventi del primo capitolo della fortunata trilogia, Capitol City si sta ancora riprendendo dalla crisi dei Giorni Bui e gli Hunger Games -istituiti al termine della guerra, 10 anni prima- sono sì una crudele punizione inflitta ai distretti ribelli, ma ancora non hanno raggiunto quel livello di spettacolarità della serie principale e non godono delle attenzioni esclusive del pubblico.
Nonostante ci si trovi in uno scenario radicalmente diverso rispetto a quello della trilogia, il lettore non si sentirà completamente disorientato in quanto conosce molto bene il protagonista dell’ultimo romanzo della Collins: Coriolanus Snow, uno dei personaggi (a mio parere) più accattivanti della trilogia, attorno al quale verterà la maggior parte di questa recensione.
Presidente di Panem freddo, calcolatore e senza scrupoli nella serie principale, Coriolanus Snow è qui un giovane studente talentuoso e mosso da grandi ambizioni, benchè ostacolato dal fatto che le condizioni economiche in cui versa la sua casata siano tutt’altro che rosee. Nonostante la famiglia sia ridotta sul lastrico, gli ultimi Snow sono animati da un bisogno viscerale di mantenere inalterato il prestigio della dinastia, e in questo Coriolanus si dimostra molto abile grazie al suo sangue freddo e alle sue capacità dissimulatorie. Perciò, anche se patisce la fame e ricorre a mezzi di fortuna per procurarsi un capo d’abbigliamento dignitoso, Coriolanus cerca in ogni modo di contenersi e di essere all’altezza di un cittadino del suo rango; nascondere la verità e salvare le apparenze sono le uniche cosa che contano, perché se non si ostenta ricchezza ed opulenza, a Capitol City si rischia di essere accostati alla feccia dei Distretti, una sorte peggiore della morte, in special modo per uno Snow. Non è infatti difficile riscontrare nei comportamenti del protagonista una certa dose di altezzosità, e ancora meno raro è coglierlo a riflettere sulla sua superiorità non solo nei confronti degli abitanti dei distretti, ma anche verso i suoi stessi compagni di scuola, atteggiamento, peraltro, che mantiene fede al motto di famiglia: «Gli Snow si posano in cima».
In tutto questo, però, l’arida verità è che la famiglia Snow è a un passo dalla miseria più nera, ma per il giovane Coriolanus i decimi Hunger Games rappresentano insieme la salvezza e la possibilità di concretizzare le proprie ambizioni. Ricevuta la nomina di mentore, se riuscisse a far sì che il suo tributo vinca, Coriolanus avrebbe la strada spianata verso il successo.
Tra le prerogative dei mentori c’è anche quella di coinvolgere attivamente il grande pubblico ai Giochi e, considerato che tra le peculiarità del protagonista figura anche un discreto carisma, non sorprende che Coriolanus sappia quale sia il miglior modo di agire in ogni situazione. Del tutto inaspettato, invece, è il fatto che il suo tributo sembra essere ancora più incline di lui ad accattivarsi i favori del pubblico, dimostrandolo già durante la mietitura: «L’abito, il trucco, i capelli. Chiunque fosse, era vestita per esibirsi. Aveva una bella voce, squillante e chiara sulle note alte, roca e intensa su quelle basse, e si muoveva con sicurezza. […] Aveva qualcosa di attraente, di seducente persino. La telecamera la divorava mentre si dirigeva sul bordo del palco e si sporgeva verso il pubblico, dolce e sfrontata». Il nostro protagonista non impiega molto a capire quanto questa dote possa risultare utile ad entrambi: «Coriolanus percepì che gli spettatori cominciavano ad apprezzare il suo tributo e non si preoccupavano più di tenersi a distanza. Era facile manipolare le persone quando c’erano di mezzo i loro figli».
Questi passi esprimono in forma embrionale uno dei motivi cardine della serie Hunger Games, ovvero quanto il dare spettacolo possa influire sui pensieri delle persone. Esibirsi e recitare una parte consente di toccare le emozioni delle persone, a tal punto da riuscire a manipolarle: più lo spettacolo è grandioso e più il pubblico abbassa le difese. Chi ha letto la trilogia sa benissimo quanto questo aspetto sia fondamentale, dal momento che i media e gli stessi Hunger Games hanno un ruolo di primaria importanza nel controllo delle masse. Si propone nuovamente, insomma, l’equazione intrattenimento = sopravvivenza, ma la novità che caratterizza il romanzo consiste nel fatto che in questo caso essa si applica non solo ai tributi, ma anche al mentore Coriolanus, come se anche lui partecipasse agli Hunger Games (e in un certo senso -senza macchiarci la fedina penale del reato di spoiler- ci si va molto vicino).
Nella Ballata dell’usignolo e del serpente i destini dei due membri principali di quest’equazione sono strettamente legati, e ciò ha pesanti ripercussioni sul protagonista, soprattutto sulla sua personalità. Come se fosse vittima di un intorpidimento o di un incantesimo, egli si comporta in maniera decisamente umana: è artefice di processi mentali inusuali per lui ed è colto da sentimenti inconciliabili con la figura del “normale” Coriolanus, tantomeno con quella del futuro dittatore. Un cambiamento senz’altro significativo nella natura del protagonista che occupa una parte del romanzo talmente consistente da poter quasi considerare questa nuova indole acquisita come la sua personalità dominante.
Alla luce di quanto appena detto, sorge spontanea una domanda: com’è possibile che questo personaggio e il temibile presidente della trilogia siano la stessa persona? Colui che asserisce il proprio controllo con la paura e il pugno di ferro, colui che elimina a sangue freddo chiunque lo possa anche minimamente ostacolare o che semplicemente si riveli scomodo o non più utile, colui che non ha alcun problema nel togliere la vita delle altre persone, che siano ribelli, bambini o persino i suoi più fidati collaboratori è veramente la stessa persona che in questo libro simpatizza per un tributo proveniente dal più squallido dei distretti? È ovvio che sia così, anche se è impossibile non notare che nel romanzo la figura che più si avvicina al presidente Snow sia la dottoressa Volumnia Gaul, la Capo Stratega. E infatti è proprio attraverso di lei che la personalità sopita (ma vera!) di Coriolanus riemerge in superficie: sebbene lo stesso protagonista sia quasi terrorizzato dalla Gaul, il suo è un ruolo fondamentale nella costruzione della natura del futuro dittatore. Le interazioni -dirette e indirette- con la Gaul hanno un’influenza enorme nel carattere di Coriolanus e in alcuni casi tale natura si manifesta in maniera così netta che tali episodi si configurano come anticipazioni a dir poco profetiche della personalità del presidente Snow della trilogia. Lampanti, a questo proposito, sono le riflessioni riguardanti il paragone tra le ghiandaie chiacchierone (ibridi di Capitol che obbediscono agli ordini dei padroni) e le ghiandaie imitatrici (originatesi per puro caso, impossibili da addomesticare e da controllare), per cui Coriolanus prova rispettivamente simpatia e odio viscerale, nonché contorto ribrezzo. Altrettanto significativo è il passo in cui Coriolanus sviluppa il tema (assegnatogli dalla Gaul) sull’aspetto che più ha apprezzato della guerra tra Capitol City e i Distretti: «Ripensò alle ultime due settimane, […], e a come tutto questo avesse riacceso il terrore che aveva provato quando Capitol City era sotto assedio. Quello che importava allora, e che importava ancora adesso, era vivere senza quella paura addosso. Perciò aggiunse un paragrafo sul suo profondo sollievo per la vittoria della guerra, e sulla cupa soddisfazione nel vedere i nemici di Capitol City, che lo avevano trattato nel modo tanto crudele, la cui esistenza era costata tanto cara alla sua famiglia, ridotti in ginocchio. In catene. Impotenti. Incapaci di fargli di nuovo del male. Aveva adorato l’insolito senso di sicurezza derivato dalla loro sconfitta. Quella sicurezza che solo il potere può dare. La possibilità di controllare le cose. Sì, ecco che cosa gli era piaciuto più di tutto».
Va detto, però, che questi sono solo barlumi fugaci e che per gran parte del romanzo abbiamo a che fare con un protagonista che si lega ad altre persone, a tratti empatico e disposto a tutto per aiutare il suo tributo, e non esclusivamente per questioni di convenienza o tornaconto personale. Ci si potrebbe allora chiedere: la caratterizzazione di Coriolanus è stata eccessivamente forzata dalla Collins deviando drasticamente da quanto stabilito nella trilogia? Senza scendere troppo nei dettagli -dove il rischio di rivelare troppo si fa elevato- possiamo affermare che nulla è stato lasciato al caso: l’autrice ha retto le redini della storia in modo tale che tutto rientrasse nei “canoni” fondati dalla trilogia. La svolta risiede nei capitoli finali, dove viene inserita la vera chiave di lettura dell’intero romanzo.
Per concludere: vale la pena addentrarsi in questo prequel? Certo che sì. Quasi alla maniera di un bildungsroman, l’aspetto della strutturazione della natura di Coriolanus basterebbe da solo a giustificare l’acquisto del libro, ma la Ballata dell’usignolo e del serpente è anche molto altro. Efficace la trama, che permette anche agli appassionati di conoscere qualcosa di più del mondo di Hunger Games nel periodo post-bellico; lo stesso vale per la caratterizzazione degli altri personaggi, specialmente Lucy Gray Baird, Seianus Plinth e la dottoressa Gaul. Buona la scrittura, che nel complesso invoglia il lettore a proseguire, anche se si abusa alquanto dei cliffhanger di fine capitolo.
Il giudizio complessivo è molto positivo. Al netto della sezione relativa ai decimi Hunger Games, forse monotona e poco coinvolgente -d’altronde la prospettiva è quella di uno spettatore e i Giochi non dispongono ancora della fantatecnologia della serie principale- si tratta di una lettura molto piacevole, d’intrattenimento, ma che si spinge anche un poco oltre. Ci si riferisce alle riflessioni sulla necessità di un controllo dall’alto per contenere la brutalità dello stato di natura dell’uomo. Sebbene vengano trattate sinteticamente, è curioso il fatto che esse portano ad una conclusione che sia l’opposto delle lotte dei libri precedenti: se nella trilogia la lotta per la libertà da un potere oppressivo è un atto indiscutibilmente lecito, qui si riflette sui pericoli di una libertà che può degenerare nell’anarchia brutale e sulla conseguente e rassicurante necessità di un controllo per prevenire il Caos.
La Ballata dell’usignolo e del serpente non è una banale appendice alla trilogia degli Hunger Games: coerente e sulla stessa linea dei tre libri precedenti, sarebbe più corretto definirli nell’insieme una “tetralogia dello Stato di Panem”. Al contempo, è un cambio di prospettiva interessante, è il rovescio della medaglia della saga principale che, se da una parte ti opprime con momenti di brutalità e tensione, dall’altra sa catturarti con il fascino del male.
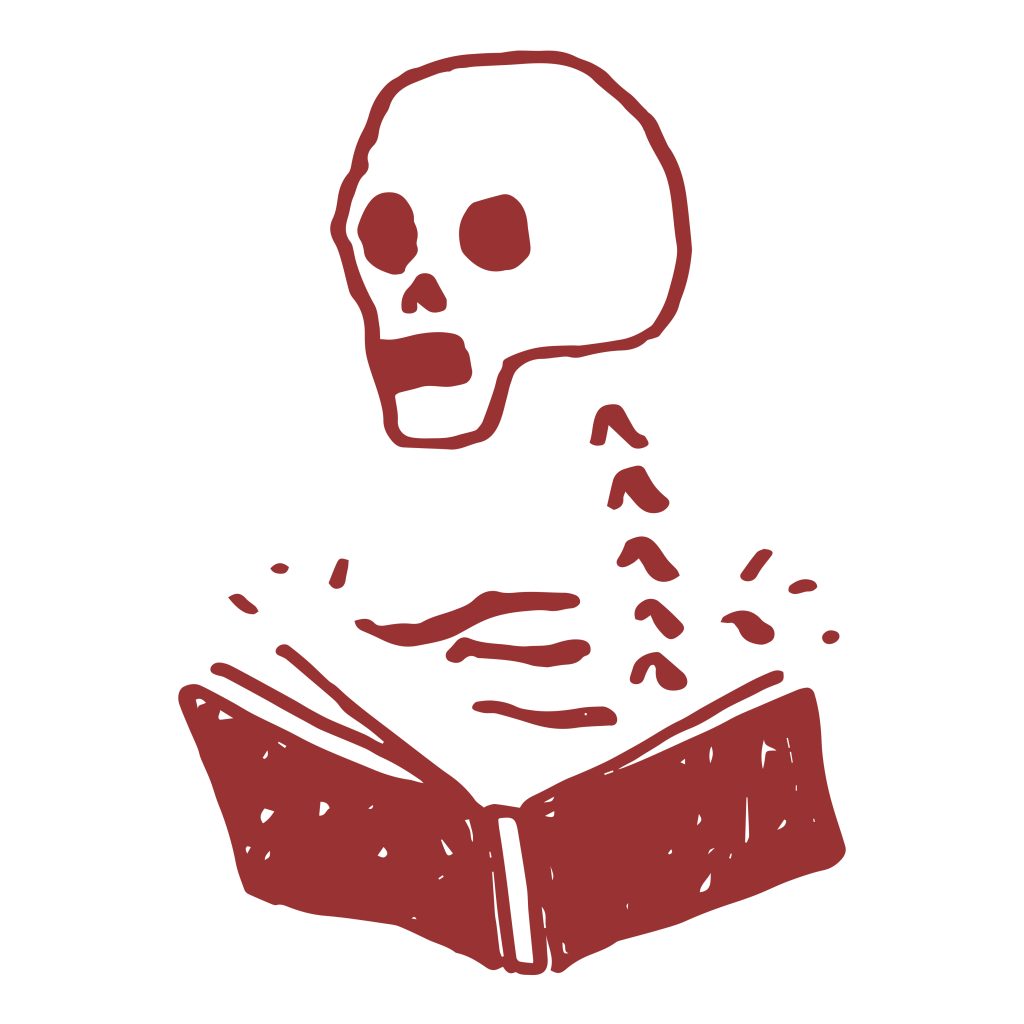
Il salotto dei morti
Chiacchiere dall'altro mondo